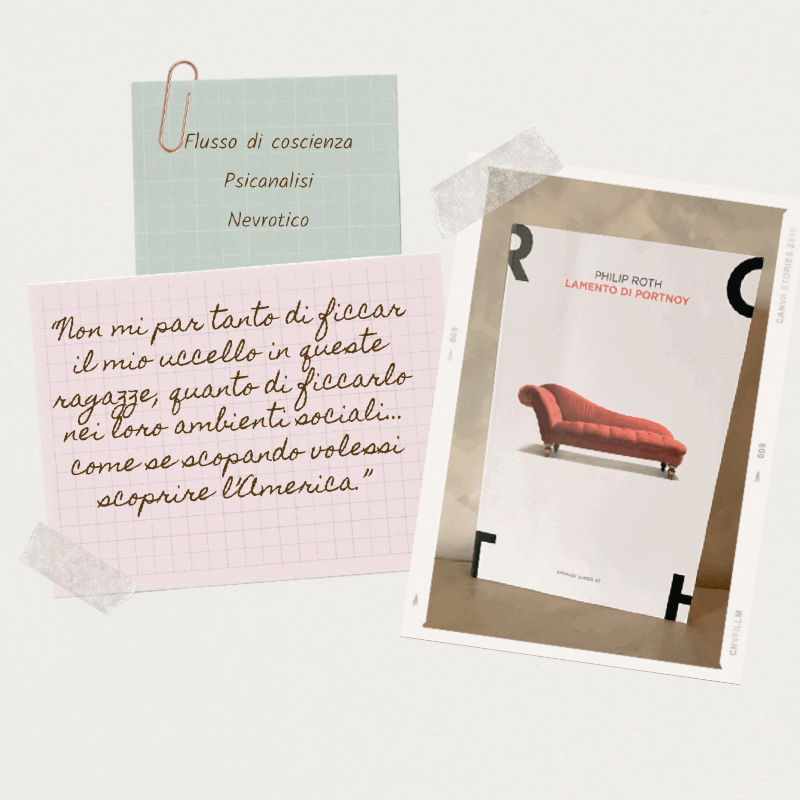Il progetto "The Bookish Reviwer" nasce dalla passione per la letteratura, con l’intenzione precisa di condividere questa passione e di ridurre la distanza tra i non lettori e i lettori, cercando di avvicinare quante più persone possibili a questo fantastico e articolato mondo.
Forte della convinzione che “L'anima di un individuo risiede nei libri che legge."
RECENSIONI
Tutte le recensioni pubblicate le trovi qui sotto.
Via col vento
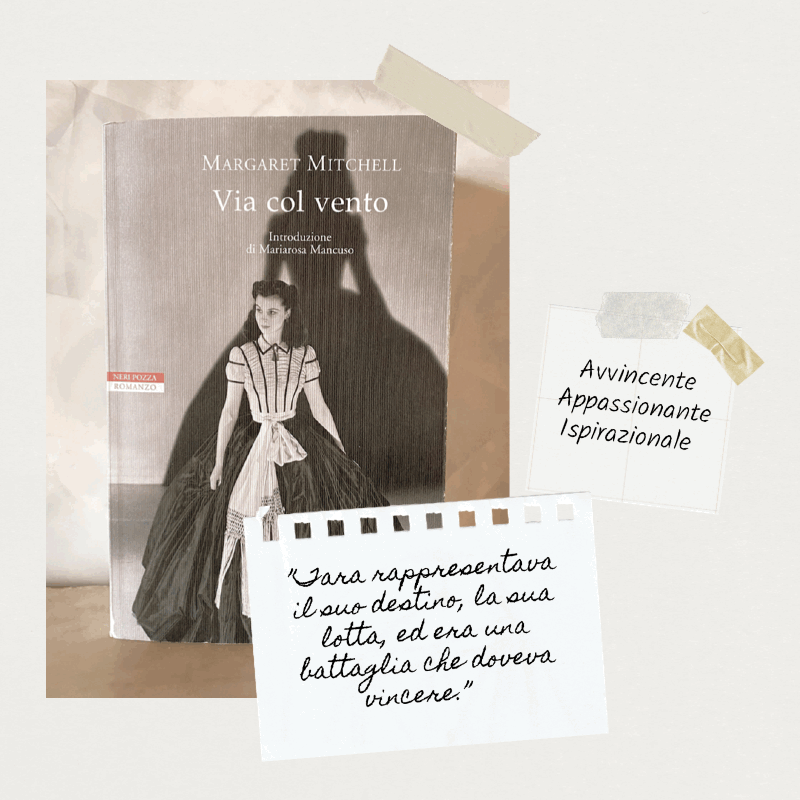
“Via col vento” è sicuramente uno dei “classiconi” della letteratura americana, un vero e proprio caso editoriale, scritto da Margaret Mitchell, tanto da vincere il Premio Pulitzer nel 1937.
L’ho letto nella nuova traduzione di Neri Pozza, curata da Annamaria Biavasco e Valentina Guani; una traduzione più “politically correct”, attenta alla nuova sensibilità culturale del pubblico, reduce dal movimento attivista internazionale “Black Lives Matter”, che pure ha indotto Hbo a rimuovere l’omonimo film dal servizio streaming secondo un’ottica di censura, a mio avviso, folle e anacronistica.“Via col vento” non va letto come il romanzo che giustifica e dipinge la schiavitù del popolo afroamericano come condizione desiderabile per la popolazione di colore stessa, ma come un romanzo, al pari di tutti i romanzi “storici”, da contestualizzare, sia all’anno in cui fu pubblicato, 1937, sia agli anni in cui è ambientato, gli anni della Guerra di Secessione.
La grandezza del romanzo non sta nell’ambientazione storica, fedelmente ricostruita, che fornisce la visione dei Confederati, sconfitti dai “volgari yankee”, bensì nell’evoluzione del personaggio principale, Scarlet O’Hara, la compianta Rossella O’Hara della prima traduzione.
Scarlet è una giovane donna, nata e cresciuta a Tara, una ricca e fiorente piantagione di cotone, che vanta circa 100 schiavi, la cui unica preoccupazione è civettare con i giovani avvenenti della sua classe sociale e trovare ben presto marito. Ma, con lo scoppio della guerra, la sua vita è destinata a cambiare drasticamente: lei, abituata a vivere nella bambagia, scoprirà cosa voglia dire lavorare e lottare per portare un misero tozzo di pane in tavola. Imparerà cosa siano fame e fatica, responsabilità e fardello; il suo carattere, già autoritario e ribelle, irlandese in tutto e per tutto come il padre, verrà forgiato da anni di stenti, rendendola una fredda calcolatrice, il cui unico pensiero è “non patire mai più la fame”, abile nel “fare di calcolo” e abile, soprattutto, negli affari.
Fa da sfondo la vecchia nobiltà sudista, caduta in miseria dopo la sconfitta della Confederazione, incapace di vivere adattandosi ai tempi nuovi, ancorata ad un passato che non ritornerà più, fedele ad un unico dettame, per sintetizzare, “mi spezzo, ma non mi piego”. Nobiltà decaduta che disprezza Scarlet per le sue capacità non adatte ad una donna, ma soprattutto perché incarna e ha fatto suo la classica mentalità yankee tanto dispregiata, “fare affari”.
“Via col vento” è anche una storia d’amore, per i più romantici e sentimentali, tra Scarlet e Ashley Wilkes, il classico gentleman del sud, sempre fedele al suo onore. Una storia d’amore utopistica, romanzesca e romanzata dalla stessa Scarlet, la quale si renderà conto troppo tardi che non si è mai trattato di amore, ma di idealizzazione del concetto di amore, per cui non c’è mai stato spazio nella vita di Scarlet, troppo pragmatica e realista per corrucciarsi su questioni d’amore.
“Via col vento” è a tutti gli effetti un grande romanzo, non solo per il numero di pagine, ma, soprattutto perché, racconta di una donna indipendente e sfrontata “ante litteram”, che lotta strenuamente per la sua indipendenza e dei suoi cari, pure considerati “fardelli”, legata da un profondo legame alla sua terra, alla sua casa, Tara.
Montana 1948
“Montana 1948” è un breve racconto, scritto come se fossero le pagine di un diario, in cui David Hayden rivive le vicende della sua famiglia accadute nell’estate del 1948.
La consapevolezza con cui narra David è quella di un uomo adulto, che ha ben compreso la portata, soprattutto morale, di quegli eventi, che, però, sono stati vissuto da un ingenuo dodicenne, che non poteva comprenderli a pieno.
Fa da sfondo il Montana, una terra spietata, come spietata è l’epoca del racconto, in cui il razzismo è ancora alla base della cultura americana e l’analfabetismo è dilagante.
In quella fatidica estate David vedrà cosa voglia dire scegliere tra la propria famiglia ed il proprio senso del dovere, tra ciò che è moralmente ed eticamente giusto e ciò che non lo è; sarà il padre, lo sceriffo Hayden, che porta sulle spalle il peso di quel nome, a prendere questa decisione. Decisione in apparenza facile, ma non quando si tratta di tuo fratello, uno stimato dottore, il figlio prediletto di un padre despota e sessista.
Wesley, il padre di David, che da sempre si è posto in secondo piano rispetto al fratello molto più carismatico di lui, che sognava tutta un’altra vita per sé e la sua famiglia, è costretto a guardare in faccia la realtà, troppe prove schiaccianti contro suo fratello.
Il senso dell’onore e del dovere costringeranno Wesley a prendere una tragica decisione, quando il fratello si macchierà addirittura di omicidio.
Questo è il punto di svolta, in cui David improvvisamente vedrà cadere tutte le sue certezze, segnando un vero e proprio passaggio dall’infazia ad un’altra fase della sua vita, passaggio sancito dal taglio netto con la sua casa, la sua terra.
“Se fossi tornato in casa - in cucina, in camera mia, se fossi uscito dalla porta sul retro, se avessi abbandonato la veranda seguendo i passi di Frank- non avrei mai sentito la conversazione tra mio padre e mia madre e forse avrei vissuto la vita conservando un’illusione riguardo alla mia famiglia e riguardo a tutto il genere umano.”
“Montana 1948” è un racconto intenso, spietato, brutale, in cui percepisci profondamente la lotta interiore dei personaggi e tutto quello che ti lascia è un forte senso di ingiustizia.
Lamento di Portnoy
“Lamento di Portnoy” non è il mio primo incontro con Philip Roth, che, invece, ho conosciuto grazie al suo famosissimo “Pastorale americana”.C’è poco da dire sulla trama: la confessione di un uomo (il divano in copertina evoca l’immagine di una seduta psicanalitica), strutturato come flusso di coscienza, Alexander Portnoy, un ebreo americano, che ripercorre la sua vita, cercando di indagare le cause della sua patologia, nevrosi ed erotomanìa.Il protagonista rimbalza continuamente tra gli eventi della sua vita, presenti e passati, soffermandosi in particolare sulla sua infanzia, in cui campeggia statuaria la madre, presenza fissa ed insopportabile durante tutto il racconto, a cui viene imputata la nevrosi del figlio. Figlio che critica, dall’alto della sua sedicente intelligenza, i genitori e le loro idee grette e razziste, eppure non riesce a staccarsi dalle “sottane della madre”, rimanendoci inevitabilmente avvinghiangato, incastrato, anche da adulto.“Lamento di Portnoy” è la storia del rapporto madre-figlio, di come la prima, inconsapevolmente, determini il carattere e le credenze del secondo; Alexander, infatti, cresce con una ferrea morale, in linea con la religione ebraica, che si scontra violentemente e tragicamente con i suoi impulsi; il protagonista non riuscirà a liberarsi dalla sua moralità, “né le fantasie né le azioni si traducono in autentica gratificazione sessuale, ma piuttosto in un soverchiante senso di colpa.”
Il “lamento” è infarcito di vittimismo e commiserazione, risultando grottesco e patetico.
Ma non è solo un romanzo generazionale, della lotta genitori-figli, è anche un romanzo socio-culturale, o come tale può essere letto, che raffigura una comunità ebraica della prima metà del ‘900, chiusa in se stessa, che non osa mischiarsi con i goy. Invece, Portnoy fa questo e tanto di più: si porta a letto solo ragazze shikses (non ebree). Lo stesso Portnoy confessa: “il succo del mio ragionamento, Dottore, è che non mi par tanto di ficcare il mio uccello in queste ragazze, quanto di ficcarlo nei loro ambienti sociali… come se scopando volessi scoprire l’America. Conquistare l’America, è forse più corretto.”
Più che entrare nell’America, Portnoy desidera penetrare se stesso e trovare una quadra, quantomeno una strada che possa aiutarlo a condurre una vita normale, altrimenti perché rivolgersi ad un psicanalista? Per stare meglio, no? Ma è davvero quello che lui vuole? O questo suo lungo soliloquio è una forma di autocelebrazione e autocompiacimento?
Nel complesso non mi ha folgorata, ma partivo con aspettative troppo alte dopo la lettura di “Pastorale americana”.
Supereroi
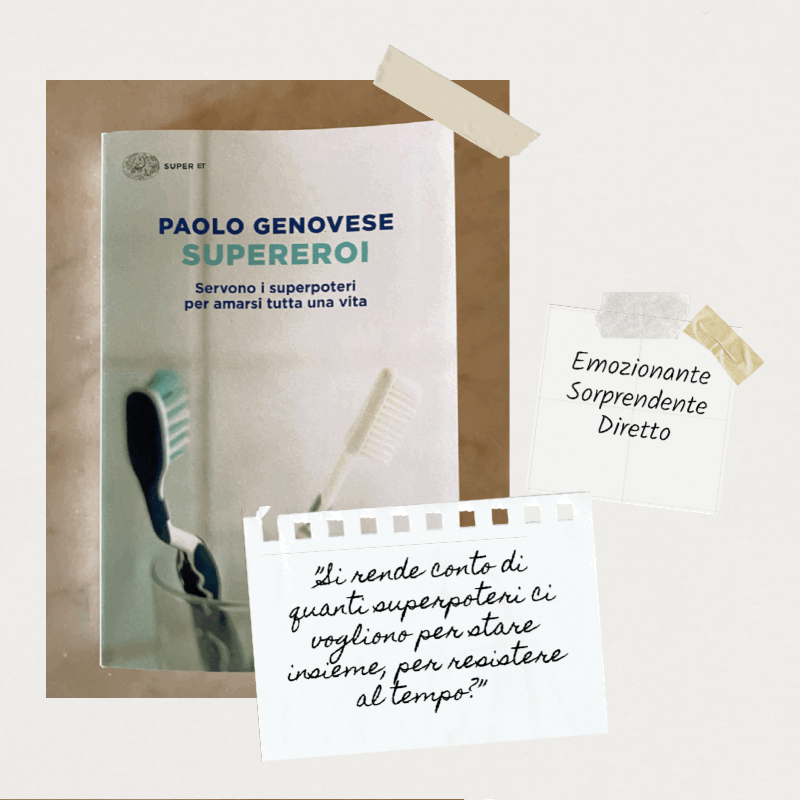
L’uomo è fatto per la monogamia? È il tema attorno al quale si sviluppa questa bella storia d’amore tra Marco e Anna, definiti da Paolo Genovese, “supereroi”. Di conseguenza, la risposta è: no, gli uomini non sono fatti per la monogamia, ma “servono supereroi per amarsi tutta la vita.”
Il grosso del problema non è amarsi tutta la vita, ma condividere interamente la propria vita con la stessa persona e svegliarsi ogni giorno con questo desiderio, vivere la quotidianità, raffigurata da una delle immagine più stereotipate della convivenza, riportata in copertina: la presenza di due spazzolini nello stesso bicchiere sopra al lavandino. Che tanto stereotipata non lo è, se ci pensi; quanti di noi effettivamente hanno la voglia di condividere la quotidianità con qualcuno che supponiamo di amare? E non parlo di quel sentimento effimero che ci porta a vivere a mille i primi mesi di relazione, che potrei definire semplice euforia, ma di quel desiderio latente, che mai si assopisce, che doveva appartenere ai nostri nonni, gli ultimi che ci forniscono l’esempio di cosa voglia dire vivere una vita insieme.Anna e Marco sono i classici opposti che si attraggono: fisico lui, disegnatrice lei; calcolatore e misurato lui, estrosa e irriverente lei; propenso alle relazioni lui, terrorizzata all’idea di una relazione lei. Anna ha, infatti, “il timore della convenzionalità”, che porta a dei lunghi silenzi, “comunicazioni tecniche, al massimo. Silenzi sempre più lunghi e sempre più normali” ai quali alla fine ci si abitua. Ma ha anche il timore di essere felice, insieme a Marco, e magari di rovinare tutto, per cui lo fa, distrugge tutto quello che potrebbe essere, che sa che potrebbe renderla felice. E lascia Marco.
“È ragionevole?” Sì, è ragionevole. Probabilmente molti di noi hanno fatto la stessa cosa.
Ma quante possibilità ci sono che due persone si incontrino per caso una seconda volta e che quella seconda volta sancisca il loro stare insieme per sempre? “Statisticamente irrilevanti.” Eppure succede e quando succede è bellissimo.Paolo Genovese, che già in “Perfetti sconosciuti” ha saputo raffigurare ed analizzare i silenzi di coppia, i non-detto, le bugie e gli inganni, in “Supereroi”, che pure ha il suo adattamento cinematografico, scandaglia in profondità la convivenza e la condivisione, parlando sì, di una coppia di supereroi, ma tanto veri e reali, che potremmo essere noi.
Da leggere tutto d’un fiato e Fabio Volo spostati proprio.
Violeta
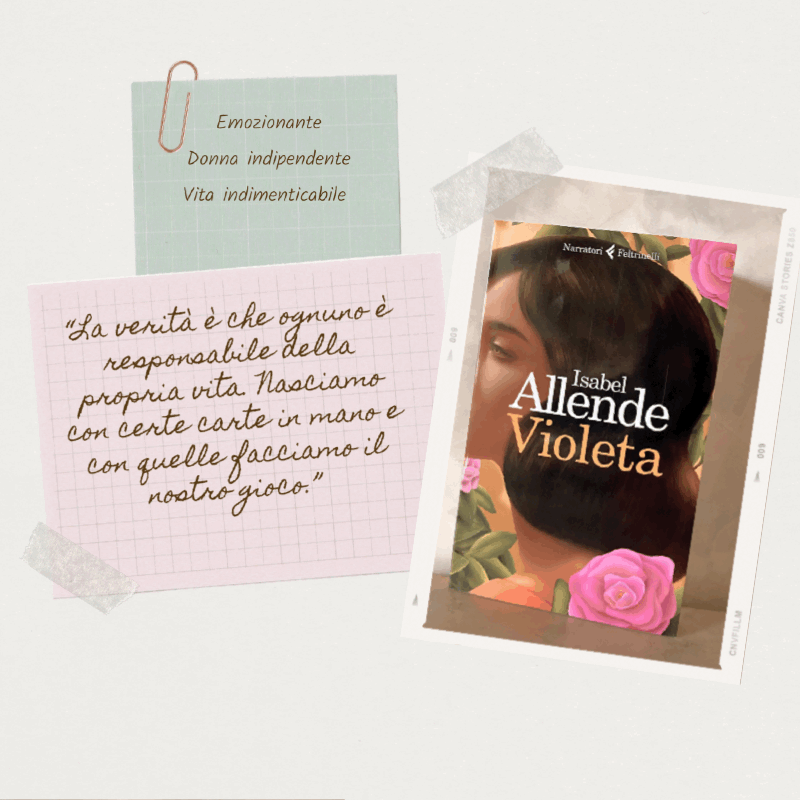
Recentemente ho letto “Violeta” di Isabel Allende, autrice che annovero tra le mie preferite, per la prosa scorrevole, chiara, cristallina, evocativa.
L’ultimo uscito della scrittrice naturalizzata statunitense narra la storia, lunga cent’anni, di una donna straordinaria, che vive esperienze straordinarie, in un’epoca straordinaria, segnata dalla Grande Guerra, dal virus della spagnola, dal “Crollo di Wall Street”, dalla guerra civile in Cile e, infine, dalla pandemia di Coronavirus. Eppure, tutti questi avvenimenti, che hanno segnato il nostro passato e gettato le basi del nostro presente, fanno solo da sfondo alla vita di Violeta, unica femmina tra cinque fratelli maschi, che capisce sin da subito che la vita è fatta di scelte, non sempre facili, anzi. Una vita ricca di incontri, molti dei quali cambieranno radicalmente la sua vita.
Violeta ha la capacità di ripercorrere, a volte con passione, a volte con freddo distacco, la sua lunga vita, perché “ricordare è il mio vizio” come confessa la protagonista, senza edulcorazioni o censure; racconta a suo nipote la sua vita nella sua interezza, con senso dell’umorismo e non senza momenti di autocritica, come ammette “sono stata testimone di molti eventi e ho accumulato esperienza, ma poiché ero distratta o forse troppo occupata non ho raggiunto la saggezza”.
Una donna che ha vissuto così a lungo e così tanti eventi notevoli non può non aver raggiunto la saggezza e questa sta nel guardare indietro ed analizzare criticamente la propria vita e la sua è sicuramente priva di rimpianti, ricca di passione e avventura.
A differenze di altri romanzi della Allende, in cui la trama storica si intreccia profondamente con la trama romanzesca dei personaggi, qui la Storia fa da sfondo, Violeta non partecipa attivamente, è totalmente calata nella sua bolla, quasi incurante di tutto quello che avviene all’esterno di essa, ma è inevitabile che eventi storici di una tale portata irrompano violentemente, costringendola a calarsi in essi e ad affrontarli coraggiosamente.
E’ una donna che non si è sottratta a nulla, ma che ha affrontato tutto quello che il destino ha posto sul suo cammino.
Un’altra prova brillantemente superata da Isabel Allende, che, posso dire, non delude mai.
Nulla, solo la notte
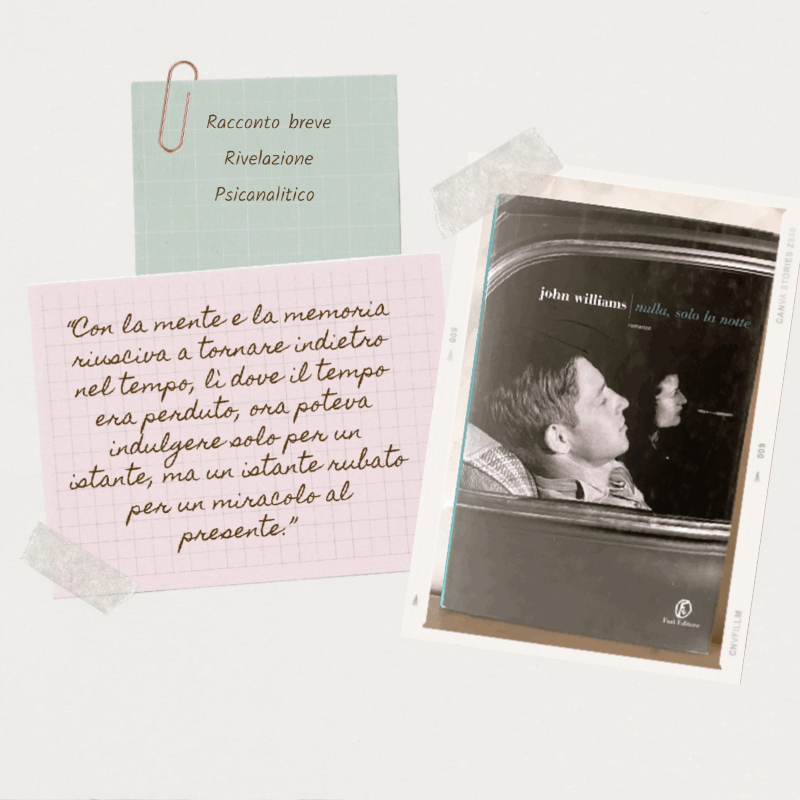
Ho conosciuto lo scrittore texano non grazie al libro in questione, ma grazie al suo più famoso “Stoner”, di conseguenza, le aspettative erano alte, ma d’altronde c’è da considerare che “Nulla, solo la notte” è un romanzo d’esordio per John Williams.
Eppure, già a vent’anni, lo scrittore statunitense mostra quello che sarà il suo tratto distintivo, ossia la capacità di ritrarre a 360 gradi personalità complesse in pochi semplici passi, in poche risicate pagine, come questo racconto, grazie ad una prosa pulita e nitida.
Ha l’arte di rendere memorabili personaggi, che, alla fin fine, di memorabile non hanno davvero nulla, anzi, sono persone abbastanza mediocri con vite altrettanto mediocri e grigie.
Come mediocre è Arthur Maxley, un giovane insicuro, segnato da un unico tragico evento del suo passato, legato alla madre, che non verrà chiarito sino alla fine del racconto stesso, come se lo sviluppo del racconto corrispondesse allo sviluppo del subconscio di Arthur, che aveva nascosto nei meandri più reconditi della sua memoria il doloroso ricordo, per poi farlo riemergere, dirompentemente. E come il buon vecchio Freud ci insegna, deve essere sempre un evento esterno che causa la riemersione di ricordi lasciati sopiti nella coscienza; per il nostro protagonista, l’evento scatenante è l’incontro con una donna, Claire, in un club a seguito di una cena finita a dir poco male con il padre, la quale pure stava riuscendo a far tornare qualche reminiscenza a galla.
“[…] c’era qualcosa, lì dentro, qualcosa che aveva riconosciuto subito, senza sapere come o perché, qualcosa che aveva già vista, qualcosa… E allora ricordò.” e il ricordo lo investe come un’onda impetuosa, che lo trascina lontano, riportandolo nella sua casa di infanzia, in cui non sarebbero mai più riecheggiate “quelle note soavi e profonde del pianoforte” né si sarebbe più sentita “la debole fragranza del profumo di lei”. E d’improvviso si trova bambino nel suo vecchio lettino, magicamente consapevole che quel momento cambierà la sua vita per il resto della sua vita, perché lo avverte nell’aria, nell’atmosfera che non è la stessa, lo avverte dalle voci dei genitori in lontananza. Quelle voci lo attirano fatalmente, portandolo nella stanza dove assiste ad un evento che non può non sconvolgere la mente di un bambino: il suicidio della madre.
“in quel vuoto eterno che durò solo l’incalcolabile frazione di un istante, tutte le forze che s’erano accumulate in lui per così tanto tempo, per ventiquattro anni, per una vita, riemersero di colpo, urlanti, e travolsero e squarciarono le porte della sua mente.”
E qui, la psiche di Arthur, già palesemente labile, si spacca definitivamente e da lettore hai la sensazione di sentire mille vetri infrangersi contemporaneamente, seguiti da un lungo, opprimente, silenzio. E’ questo quello che ti lascia Williams con questo breve, incisivo, racconto: un opprimente silenzio.
La metà scomparsa
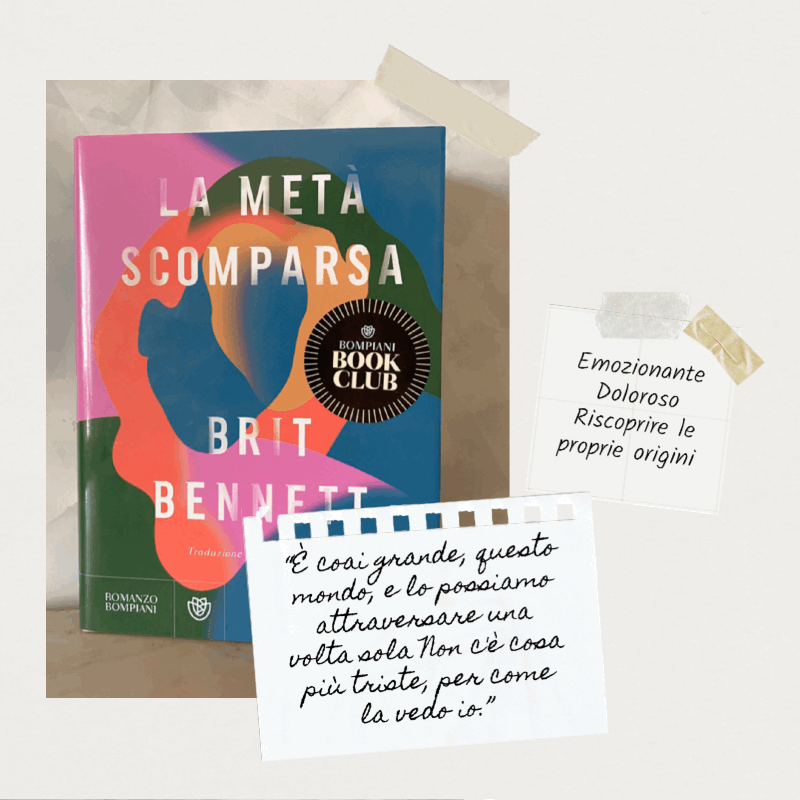
Quanto può far male perdere una persona cara, soprattutto se quella persona è la tua sorella gemella, con la quale hai condiviso tutto? Quanto fa male quando questa persona decide di troncare di netto ogni legame, volutamente? Farebbe male come amputare un arto, probabilmente, e quel dolore te lo porti dentro, sempre, latente, mai attenuato, lo trascini con te come un moncherino, che a volte fa più male del solito.
“La metà scomparsa” di Brit Bennett, edito Bompiani, riesce a farti vivere questo dolore, il dolore di Desiree Vignes, che perde la sorella Stella, dopo aver deciso di fuggire insieme da quella landa desolata che è Mallard, fuggendo di notte, senza lasciare alcuna traccia, nemmeno un bigliettino per i genitori.
La prospettiva di costruirsi il proprio futuro in una città più grande è molto più allettante che crescere in un posto come Mallard, in cui l’unica prospettiva era finire a lavorare come cameriera in una casa di qualche ricca famiglia di bianchi.
Mille possibilità si aprono alle due giovani sorelle, il cui unico desiderio è fuggire, non solo dalla casa dei genitori, ma da loro stesse, e Stella questo lo capisce, molto più di Desiree. Per questo decide di lasciare la sorella e fuggire ancora, per fingersi quella che non è, una giovane ragazza bianca. E da qui la vita di Stella seguirà una strada completamente diversa da quella della sorella.
Desiree torna a Mallard, dai suoi genitori, sedici anni dopo, portando con sé sua figlia, una bambina dalla pelle scurissima, di nome Jude. E a Mallard questo non va bene, perché è sì, un pese di “neri”, ma di neri dalla pelle chiara, che disprezzano gli altri neri; mentre Stella conosce e sposa un uomo bianco, tessendo una maglia di bugie, di cui sarà inevitabilmente prigioniera. Perché se hai mentito troppo a lungo e su cose così importanti, come la famiglia e le proprie origini, arrivi ad un punto di non ritorno e l’unica cosa da fare è continuare nella farsa, senza guardare mai indietro. E Stella non lo fa, guardare indietro, fino a quando un incredibile insieme di coincidenze non la costringe ad affrontare i propri mostri e il proprio passato.
La Bennett riesce a rappresentare il coraggio di lottare per diventare ciò che davvero siamo, il dolore della perdita e il legame con le proprie origini, in un romanzo sorprendente, che tocca temi di grande attualità.
Mexican Gothic
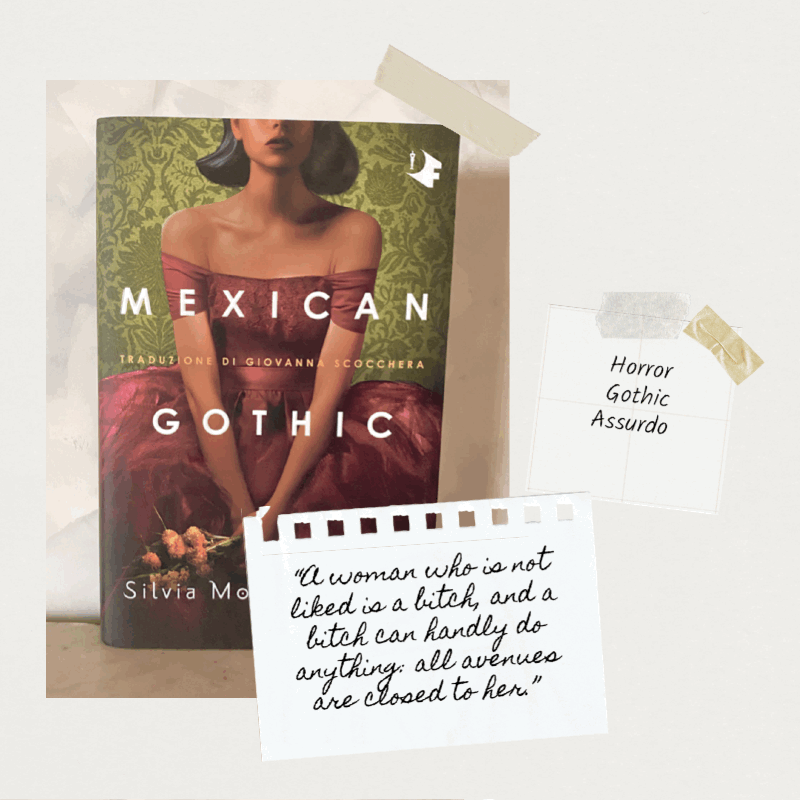
Gli elementi per un’agghiacciante avventura dalle tinte cupe e tenebrose, per cui ho una malsana propensione, ci sono tutti: una tetra dimora decadente, un affascinante lord inglese e un mistero di famiglia. Peccato che manchi tutto il resto. “Mexican gothic” è un romanzo che tenta di essere horror, ma non lo è.
La trama poteva anche andare: a seguito di alcune lettere allarmanti da parte della cugina Catalina, Noemi Taboada, la protagonista, deve recarsi ad High Place, l’antica dimora dei Doyle, per assisterla e scoprire cosa si cela dietro quei deliri di Catalina. L’atmosfera gotica della casa è ben tratteggiata dalla penna di Silvia Moreno-Garcia, così come un progressivo senso di oppressione e pericolo.
Non sto qui a dilungarmi più di tanto sulla trama, perché tutto ciò che di interessante ha all’inizio si smorza non appena questa si chiarisce.
E’ vero, non è scontata, ma talmente tanto assurda, se questo aggettivo si può utilizzare in merito ad un romanzo horror, da deludermi.
Sarà perché sono legata ancora alle care vecchie storie paranormali su fantasmi e possessioni, ma questa storia non mi ha colpito per nulla.
Deludente, già l’ho detto?!
Non voglio spoilerare il finale per chi di voi ancora non l’ha letto; se ci tenete, lo leggerete da voi.
Nice try. Magari, se l’autrice ritenta, sarà più fortunata.